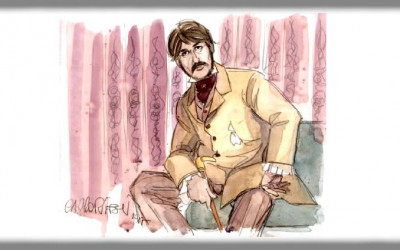Chi va nel paese di Pennabilli e sale sul Roccione, l’altura da cui si spazia con lo sguardo sulla Val Marecchia, troverà davanti a sé, unite da un telaio, una campana cristiana e tre ruote della preghiera tipiche del buddismo tibetano. Le ruote e la campana suonano in modo diverso, ma raccontano la stessa vicenda. Una storia avventurosa, che ci porta indietro di quasi tre secoli e in avanti di molte migliaia di chilometri. Se siete pronti, cari amici e care amiche di RadioEmiliaRomagna, possiamo partire e ripercorrerla insieme.
Sul finire del 1680, tra le balze di Penna e Billi, come allora si chiamavano i due nuclei del paese, nasce l’ultimo figlio del conte Olivieri. Il suo nome è Francesco Orazio. Circa venti anni dopo, il ragazzo lascia il castello di famiglia per entrare nell’ordine francescano: diventa un frate cappuccino e va a stare nel convento di Pietrarubbia. Proprio in quell’epoca, ai primi del Settecento, la Chiesa cattolica, con la Congregazione “de Propaganda Fide”, progetta di diffondere la fede cristiana anche tra il Gange e le vette dell’Himalaya, affidando la missione ai francescani. Neanche mezzo secolo prima, a Lisbona, la relazione del gesuita portoghese De Andrade aveva fatto risuonare in Europa il nome di un luogo remoto, sperduto tra quelle altissime montagne: quel luogo si chiama Tibet.
Le prime due missioni dei cappuccini dirette a Lhasa, la capitale del regno tibetano, riescono a stabilire con molta fatica un primo contatto, ma solo con la terza, partita dalle coste della Bretagna nell’agosto del 1712, quel primo approccio viene consolidato. Di questa spedizione fa parte anche il trentaduenne frate Orazio, che imbarcatosi nel porto di Lorient su una nave della Compagnia francese delle Indie Orientali, tocca terra a Chandernagore, nel Bengala, dopo un anno di navigazione. Poco più tardi, il drappello di frati raggiunge la città di Patna, sul fiume Gange, da dove partono le carovane dirette verso l’interno, sulle piste dei mercanti olandesi che trasportano oppio, tessuti e tappeti. Ma il viaggio dall’India al Nepal è irto di pericoli, occorre attraversare indenni le paludi del Terai, sopravvivere agli attacchi di animali affamati e alle pretese dei gabellieri, che a ogni tappa estorcono un po’ di denaro ai missionari.
La terza base della missione è in Nepal, nella valle di Kathmandu, dove i cappuccini arrivano all’inizio del 1715, trovando una situazione di caos dovuta alle frequenti lotte tra i tre regni in cui era diviso questo territorio. La sosta dura quasi un anno, durante il quale bisogna fronteggiare anche un’epidemia che colpisce il paese. Quando i sacerdoti indù addossano la colpa del morbo al colore del saio francescano, i missionari non si perdono d’animo e si vestono di azzurro.
Il Nepal è la porta naturale per chi vuole raggiungere l’altopiano del Tibet. Ma nel mezzo si frappone un ostacolo enorme: la grande catena himalayana, con piste, gole e sentieri impervi. E i leggendari ponti catenati sospesi su abissi di vuoto, da attraversare oscillando come su una culla. Dopo quasi un mese, ai primi di ottobre del 1716, i cappuccini (in tutto tre) arrivano a Lhasa, attivissimo crocevia commerciale tra India, Cina e Mongolia. Portano la croce, simbolo della resurrezione, in un paese che crede fermamente nella trasmigrazione delle anime, in cui la religione è amministrata dai lama, i sacerdoti buddisti, che, come scrive Orazio nella sua relazione, “son quelli che, morendo, credonsi passare da un corpo all’altro”. I frati sono bene accetti perché stringono amicizie e, grazie alle loro conoscenze mediche, sanno curare molte malattie, ma non possono fare proseliti, se non tra gli stranieri di passaggio. I tibetani, annota Orazio “si dimostrano docili ed umani, sottomettendosi al ragionevole”, a parte i religiosi, però, che “si rendono più pertinaci in difesa di loro setta”.
La terza missione francescana in Tibet, tuttavia, può dirsi fortunata. Dura ben sedici anni, durante i quali il paese conosce scontri di potere ai vertici del regno, l’invasione degli Zungari e l’arrivo dell’esercito cinese. Nonostante tutto, i cappuccini, che i tibetani ormai chiamano “lama dalle teste bianche”, si sono guadagnati il privilegio di acquistare un piccolo pezzo di terra dove erigono un ospizio e una chiesetta. Frate Orazio, che è stato nominato prefetto della missione, ne ha approfittato per studiare la storia, la geografia e le istituzioni del luogo, e soprattutto la lingua: il suo dizionario tibetano-italiano, forte di ben 35.000 vocaboli, è il primo tramite culturale tra l’Europa e questo angolo di mondo e sarà la base su cui, un secolo dopo, sarà messo a punto il dizionario inglese.
Nell’agosto del 1732 frate Orazio riparte alla volta dell’Italia: la missione può contare solo sulle forze di un altro uomo, oltre alle sue, e c’è bisogno di altre risorse. Il viaggio dura quasi quattro anni, con una spiacevole parentesi di cinque mesi nel carcere di Kathmandu. Giunto finalmente a Roma, ottiene l’appoggio del papa Clemente XII e di un cardinale, che gli forniscono denaro, altri dieci missionari, doni per il reggente del regno himalayano e un’attrezzatura tipografica con cui stampare libri e documenti nell’alfabeto tibetano. Sembra che, prima di riaffidarsi agli oceani, il cappuccino abbia fatto in tempo a rivedere Pennabilli.
Quando la nuova missione torna a Lhasa, ai primi di gennaio del 1741, il buon ricordo lasciato dai francescani, i doni elargiti e una situazione interna più stabile fanno sì che i governanti lascino più spazio ai tentativi di evangelizzazione, con tanto di documenti ufficiali che consentono a chiunque di seguire la religione dei “lama bianchi”. “Che Iddio si compiaccia di illuminare queste povere Anime per conoscere la vera Legge, per evitare le pene dell’Inferno ed acquistare la gloria del Paradiso”: così scrive Orazio in una lettera al fratello. Qualche mese dopo, però, quando alcuni dei primi tibetani convertiti si rifiutano di pagare i tributi dovuti ai monasteri buddisti, la reazione dei lama veri e propri è dura. Gli anni successivi, perduto gradualmente l’appoggio del reggente, sono difficili, finché nella primavera del 1745 tutti i francescani sono costretti ad andarsene. Di lì a poco, in Nepal, dove si sono rifugiati, arriva la notizia che l’ospizio di Lhasa è stato distrutto. Frate Francesco Orazio della Penna, già malato, non regge al dolore e si accascia: morirà nell’estate di quell’anno.
La gran parte delle tracce di questa storia sembravano perdute, come i caratteri mobili della stamperia portata dai frati a dorso di yak o come le traduzioni dei testi tibetani pazientemente compilate da Orazio. Invece, qualche anno fa, è stata ritrovata la campana che i francescani avevano issato sul loro piccolo convento. Era nel tempio di Jokhang, uno dei più importanti di Lhasa, ed è scampata anche alla repressione antibuddista messa in atto dalla Cina dopo l’invasione del Tibet, nella seconda metà del Novecento. Nel 1994, quando il Dalai Lama è venuto in visita a Pennabilli per la prima volta ed ha ascoltato il suono della campana registrato nella città sacra che anche lui, costretto all’esilio, aveva dovuto lasciare, non ha trattenuto la sua emozione. Di quel frate, che pure era venuto in mezzo a loro per portare un’altra religione, ha ammirato il coraggio e la capacità di entrare in contatto e in armonia con un mondo differente. Quando è tornato di nuovo, nel 2005, il Dalai Lama ha inaugurato la campana che ricalca quella originale rimasta in Tibet e i tre mulinelli usati dai buddisti per affidare al vento i loro mantra. “Te Deum laudamus” e “Om Mani Padme Hum”: campana e ruote portano impresse queste preghiere. Sei sillabe scritte in due lingue diverse per chiedere la stessa pace.