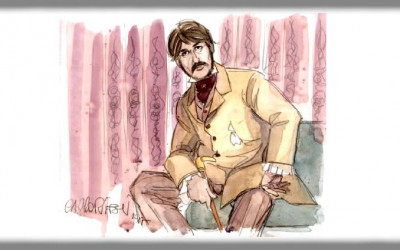Care amiche e cari amici di RadioEmiliaRomagna, la protagonista di oggi è una donna di origine indiana che ha lavorato in una cooperativa di facchinaggio di Campegine, nel Reggiano, finché non ha chiesto, insieme ai suoi compagni di lavoro, di essere inquadrata con un regolare contratto collettivo. Le vicende e l’esito della sua storia le ha raccontate lei stessa al giornalista Loris Campetti, che ha inserito il caso nel libro intitolato “Non ho l’età. Perdere il lavoro a 50 anni”, pubblicato nel 2015 da Manni Editori. Ascoltiamo le sue parole.
Il mio nome è Goghi, tutti mi chiamano così. Non mi interessa l’anonimato perché le cose che ho da dire le ho gridate sia davanti all’azienda che ai poliziotti che volevano convincerci a togliere il presidio e a sospendere lo sciopero della fame e della sete; le ho ripetute in piazza a Reggio Emilia e nella sede della Provincia quando l’abbiamo occupata. A quelli della Digos che mi suggerivano di non andare in giro in bicicletta da sola per non correre rischi, dato che avevo ricevuto non poche minacce, e forse anche per delle informazioni riservate che avevano loro, ho risposto che dalle mie parti, in India, se si viene ammazzati si diventa fantasmi. E i fantasmi ritornano, se mi fanno fuori torno nella veste di un fantasma a fare i conti con i colpevoli e li sistemo tutti quanti.
Non chiedetemi che lavoro vorrei fare da grande, intanto perché sono già abbastanza grande e i miei 50 anni me li sono lasciati alle spalle. E poi il problema non è quale lavoro vorrei fare, ne ho fatti tanti, dal circo alla fabbrica, dalla stalla al forno e alla cucina, posso farne anche altri. Il lavoro non mi spaventa, però non sono più disposta a lavorare per una cooperativa, né a fare la schiava sotto qualsiasi padrone. Perché la verità è che oggi chi lavora in Italia è senza diritti, dunque è uno schiavo.
Sono nata in India, nel Punjab, al confine con il Pakistan. Mia mamma era sindaco del paese. Sono venuta in Italia nel 1986 per raggiungere mio marito, anche lui indiano, che quando era stato costretto a scappare dall’Iran, dove era scoppiata la guerra con l’Iraq, era venuto al circo “Miranda Orfei” a fare l’elettricista, seguendo gli spostamenti della struttura in giro per l’Italia, dove si tenevano gli spettacoli. Per due o tre mesi sono rimasta anch’io a lavorare al circo, finché sono rimasta incinta, e siccome avevo una gravidanza difficile mi ricoveravo da un ospedale all’altro, a seconda di dove il circo faceva tappa. Quando il circo ha chiuso siamo andati a Città di Castello, invitati da un amico indiano conosciuto a uno degli spettacoli. A Città di Castello è nata mia figlia.
Nel ’90 ci siamo trasferiti nel Reggiano e io ho lavorato nel ciclo agricolo del tabacco. Tre anni dopo, ho lasciato il tabacco e sono andata a lavorare in una stalla, anche se i padroni del tabacco volevano portarmi in fabbrica, dove si completa la lavorazione del prodotto. Mi dicevano anche “Ti paghiamo il biglietto noi, vai in India e porta un po’ di persone che qui abbiamo bisogno di bravi lavoratori come te”. Non ho accettato, mi trovavo meglio a lavorare nella stalla dove guadagnavo il doppio, anche se il lavoro era duro e le mucche mangiano pure il sabato e la domenica.
Nella stalla sono rimasta diversi anni. I proprietari sono stati la mia nuova famiglia, i miei figli (una femmina e un maschio più giovane) chiamavano il proprietario “nonno bianco” per il colore dei suoi capelli. Ero trattata bene, venivano a prendermi a casa in automobile per portarmi al lavoro. Quando l’azienda è stata venduta a della gente di Brescia e i nuovi padroni hanno preteso di abbassarmi lo stipendio e accelerare i ritmi produttivi me ne sono andata a lavorare in una ditta di Poviglio, nella Bassa reggiana, a fare i bancali di legno.
I bresciani sono venuti a cercarmi a casa promettendo di mettermi in regola con il contratto ma io sono una che non si piega e ho preferito restare in fabbrica con uno stipendio più basso, così per ritorsione hanno licenziato mio marito che era rimasto a lavorare per loro, anche se poi sono stati costretti a riprenderlo. Poi, nel 2001, mio marito è morto [in seguito al calcio ricevuto da una mucca che stava mungendo: in ospedale avevano sottovalutato la gravità della situazione e il marito di Goghi è morto dissanguato nel suo letto; nota dell’autore]. Sono rimasta ai bancali, ma quando hanno preteso di farmi lavorare di più a parità di salario, pensando che essendo morto mio marito avessi più tempo disponibile, ho litigato, ho preso su e me ne sono andata a lavorare in una nuova stalla.
Nel 2003, dopo un po’ di nero, sono entrata in fabbrica con la GFE (Gruppo facchini emiliani) aderente a Lega Coop. Si faceva etichettamento e imballaggio di materiale tessile per la SNATT, un gigante della logistica che immagazzina e distribuisce tutte le principali griffe del settore, da Polo a Dolce&Gabbana, a Cisalfa. Eravamo fino a 516 dipendenti, in maggioranza indiani, soci con contratto a tempo indeterminato, però un regolamento interno alla cooperativa consentiva di eluderlo. Ma noi che ne sapevamo? Quando non c’era lavoro noi soci venivamo lasciati a casa, a volte mi arrivavano buste paga senza una lira, o addirittura ero io che dovevo dare indietro dei soldi e solo più tardi abbiamo scoperto che se lavoravamo meno di 15 giorni al mese perdevamo ferie, assegni familiari e contributi.
I salari erano bassi, inferiori a 7 euro lordi l’ora, che potevano addirittura scendere a 3,9 euro netti. Io avevo proposto che si lavorasse a rotazione, per evitare che gli operai con famiglia, che dovevano tirare su dei figli, fossero penalizzati più degli altri, ma quelli lì non ci vollero sentire. Con il peggioramento delle condizioni di lavoro abbiamo cominciato a mobilitarci, anche perché girava voce che la coop volesse chiudere per poi riaprire con un nome diverso. Il consiglio di amministrazione era completamente controllato dalla SNATT. Bloccammo i cancelli per conquistare un vero contratto, con assemblee a cui partecipavano anche 300 soci.
A novembre del 2011 ci arrivò una lettera in cui ci si diceva che l’indomani non avremmo dovuto presentarci al lavoro. Naturalmente andammo ugualmente e, trovando i cancelli chiusi, decidemmo di restare in presidio. La SNATT aveva disdetto il contratto e la metà dei soci erano stati convinti a dimettersi con la promessa che sarebbero stati assunti da altre due cooperative nate dalla liquidazione della GFE. Ci hanno divisi, in 185 abbiamo rifiutato di aderire alla richiesta e abbiamo fatto una lunga lotta. Noi abbiamo continuato il presidio ai cancelli di Campegine, sostenuti almeno all’inizio anche dalla CGIL.
Quando abbiamo cominciato uno sciopero della fame e della sete durato cinque giorni, le acque si sono subito agitate, è intervenuta la Regione Emilia-Romagna per far pressione su di noi, sono intervenute la polizia e la DIGOS e infine la CGIL ci ha convinti a lasciare liberi i cancelli e trasferirci a Reggio occupando la Provincia. Il 14 giugno, al termine di una trattativa alla sede della Regione, abbiamo raggiunto un accordo che ci garantiva cassa integrazione e mobilità, che mi ha coperto da un punto di vista salariale con 600-800 euro fino al 2014.
Quando abbiamo cominciato a prendere coscienza del fatto che in cooperativa i nostri diritti erano violati quotidianamente, iniziando un po’ di controlli abbiamo scoperto che il presidente era un prestanome e che tutte le decisioni venivano prese senza mai coinvolgere noi soci. Eravamo anche riusciti a riprendere in mano la situazione costituendo un nuovo consiglio di amministrazione di cui anch’io facevo parte, ma con il fallimento è stato tutto inutile.
Dopo l’accordo in Regione ho dedicato tutto il tempo e l’impegno a trovare una sistemazione per le persone che avevano sostenuto la lotta insieme a me e che come me una domenica di novembre erano stati licenziati con un sms sul telefonino. In 185 avevamo promosso una vertenza legale contro la SNATT che aveva mosso le fila di tutta l’operazione, ma il 14 luglio del 2012 è arrivata la sentenza del giudice: ci ha dato torto, e io ho versato un fiume di lacrime, infine mi sono tirata su le maniche un’altra volta.
Adesso faccio la nonna a tempo pieno e a volte vado a dare una mano al forno di mia figlia. Per tirare su qualche soldo faccio da mangiare nella casa della bonifica, dove vivo pagando un affitto di 100 euro al mese, ma l’ho rimessa in sesto ed è grazie al mio lavoro che oggi si tiene in piedi. Durante il terremoto ho anche ospitato una famiglia di indiani con tre bambini rimasti senza casa. Preparo le samosa, un piatto popolare indiano fatto di fagottini di pasta ripieni di patate, cipolla, e piselli per due negozi della zona a cui preparo anche altri fritti. Inoltre lavoro qualche ora a lavare e nutrire i cavalli. Dimenticavo il volontariato presso una casa di cura.
Ora sono cittadina italiana e non tornerei in India, mio marito non c’è più e non ci sono più troppe cose, starei solo male con un fardello pieno di tutti i miei ricordi. Da qui non scappo. Quando era ancora vivo, accompagnavo mio marito – lui era credente – al tempio sikh di Novellara. Io non sono credente, o meglio in qualcosa credo: nell’umanità. L’esperienza alla GFE mi ha lasciato tanta amarezza e dolore. Però mi ha fatto incontrare una nuova famiglia cresciuta nella lotta, ho incontrato il sindacato, nelle sue persone migliori che mi hanno sostenuta e anche nelle sue parti meno nobili che hanno marginalizzato chi aiutava noi indiani. Il PD, che dalle nostre parti governa tutto, non s’è mai visto, anzi, qualche volta si è fatto vedere ma stava dall’altra parte, dalla parte di chi ci ha licenziati.
Ho parenti in giro per il mondo, una sorella a San Diego, un’amica a Londra, mi offrono rifugio da loro ma io sono Goghi, una cittadina italiana che combatte qui le sue battaglie. Ho presidiato fabbriche e occupato la Provincia, ho manifestato in piazza, sono stata accusata dai poliziotti di lanciare uova e sapete cosa ho risposto? Ho risposto che le uova le mangio, se decidessi di tirarvi qualcosa non sarebbero certo uova ma qualcosa che riconoscereste dall’odore. Ho partecipato ad assemblee nelle scuole, nei centri sociali, nelle feste politiche, soprattutto per dire ai ragazzi che quel che capitava a me doveva interessare prima di tutti loro che sono giovani; devono capire in che situazione si troveranno a vivere e cercare lavoro. Adesso ho scoperto che per quel brevissimo periodo che sono stata nel consiglio della GFE prima del fallimento, rischio di dover pagare i creditori. Sembra uno scherzo, ma mi dicono che non lo è.