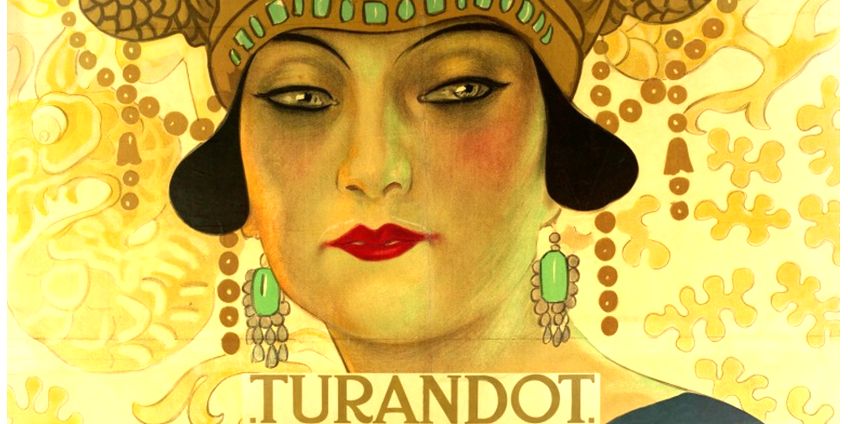Economista, docente universitario e assessore regionale alla scuola, alla ricerca, allo sviluppo e al lavoro, il ferrarese Patrizio Bianchi ha dedicato alla sua passione per l’opera italiana una trilogia che è diventata anche spettacolo, con la sua voce narrante e le musiche eseguite dalla Banda giovanile “John Lennon” diretta dal maestro Mirco Besutti. Ve ne leggiamo la parte finale.
Il Barbaja è di Milano
e fa il cameriere in un caffè,
comincia la sua carriera di barman
mettendo la schiuma del latte
nel caffè, chiama questo cappuccino
Barbajada e comincia a far soldi,
tanto che durante le guerre napoleoniche
compra e vende armi e munizioni,
al punto da vincere l’appalto
per il gioco d’azzardo
al Nuovo Teatro alla Scala
e di prendere la gestione
di tutto, azzardo, ristorante,
qualche sfizio in più a richiesta
dei gentili signori, e infine anche
dello spettacolo, compreso però
il gran ballo alla fine di ogni recita
e i veglioni ad ogni festa comandata.
E poi prende l’altro teatro di Milano,
quello che oggi è Il Lirico,
due teatri a Vienna, e poi il San Carlo di Napoli,
il teatro della capitale
più briosa del tempo.
E in questo impero teatrale
Barbaja si inventa i suoi autori
Rossini, Bellini, Donizetti,
gente che lui prende su dal niente,
li fa scrivere e li paga a serata,
tante repliche, tanto soldo
e non importa se riciclano.
Basta che il pubblico si diverta,
che giochi, che si faccia vedere,
che spenda i dinè, arte e dinè.
E inventa le primedonne,
prende ragazzotte in crescita
‒ le prende in tutti i sensi ‒
e le fa cantare; se fanno cassa
diventano le nuove dive
di questo nuovo pubblico,
fatto di uomini nuovi,
molti dei quali si sono fatti da sé.
Le trasforma nelle loro divinità,
divinità a rapida consumazione
ma dive, per le quali gli autori a cottimo
scrivono drammi e farse,
requiem e carnevali, perché il teatro
deve essere sempre aperto e illuminato,
anche dalle guerre fra le dive, le star.
Quando la Colbran arriva a Napoli
era già una stella. Era nata a Madrid,
ma aveva studiato a Bologna.
Aveva già avuto i suoi successi
ma a Napoli incontra Barbaja,
diventa la sua amante
e lì incontra Rossini e diventa la sua amante,
e comunque la primadonna di tutti e due,
l’interprete di tutte le opere, la diva di tutti i successi.
Si sposa con Rossini, mettono su casa a Castenaso
con i soldi dell’eredità di lei
ma si dividono e lui, già in preda a una melanconia
così lontana dalla sua musica, va a Parigi.
Lei muore sola, perduta, abbandonata
nel popoloso deserto chiamato Bologna
‒ lo so che a Bologna non si perde neanche un bambino ‒
mentre lui si risposa a Parigi e non scrive più,
solo una Messa in cui usa gli ultimi castrati.
Ma la scena continua e Barbaja si consola
con la Cecconi e con nuovi autori,
perché lo spettacolo continua.
Anche il giovane Verdi entra in questo tourbillon,
Marelli prende il posto di Barbaja alla Scala
ed emergono la Giuditta Pasta e la Maria Malibran
e i loro fan, i due partiti che si schierano
urlando, fischiando, applaudendo le loro dive.
Donne in viaggio tra Milano, Parigi, Londra, Vienna, Napoli,
donne indipendenti, con diversi legami amorosi
e anche figliolanze sparse, in un’epoca
in cui la morale ordinaria era ancora del tutto restrittiva
ma a loro e ai loro impresari si permetteva
il successo garantito dalla straordinarietà
della loro situazione esagerata;
eccessive in tutto e come tali diverse,
stelle di un cielo separato e spesso stelle cadenti,
in un mondo che chiedeva sempre carne giovane.
Le mura di casa Verdi
La Strepponi prima di arrivare fra le robuste
mura di casa Verdi, nella noia di Sant’Agata,
aveva vissuto tutta la trafila di amanti e successi,
solitudini e declini, figli lasciati e famigli famelici.
E Verdi stesso ci mette un bel po’ prima
di sposarla, quasi in segreto, molti anni dopo.
Ma la soprano è lì in mezzo al palco
a cantare amori tristissimi e sventurati
o anche inni di guerra e libertà,
emblema di un’opera che diventa
la voce di nuove nazioni subito gelose,
dall’Italia alla Germania.
L’opera costruisce un’epopea nazionale artificiale
come la Spagna di Carmen o l’Egitto di Aida,
o le isole lontane dei pescatori di perle.
Ma l’Ottocento degli esploratori e dei nazionalismi
ha bisogno dei suoi palcoscenici e primadonna
diventa il simbolo cangiante della sua epoca.
Così, dopo la fase eroica della costruzione
della patria, segue la fase della delusione
e allora l’opera ha bisogno di altri eroi.
L’opera si interessa di povere donne,
le sartine parigine, le gheishe abbandonate,
ma è Tosca la più primadonna di tutte.
Tosca è una primadonna sulla scena
e canta per la Chiesa e ha un amante,
quello scioccone del pittore Cavaradossi,
che si trova in mezzo a una vicenda
più grande di lui, complice nella fuga
di un prigioniero di Stato,
negli anni in cui Roma, pressata da Napoleone,
era ben sotto la polizia papalina.
E quando il barone Scarpia, lo sbirro,
prende lo scioccone per farsi dire
dove trovare il fuggiasco e chiede
alla primadonna qualcosa
in cambio della libertà dell’amante,
la donna di mondo non capisce e domanda:
«Quanto?». E Scarpia, uomo di mondo,
le dice: «Se la adorata fe’ debbo tradir
ne voglio altra mercede» e tutti in platea
e sui palchi, dandosi di gomito,
si chiedono con un risolino:
«Cosa vorrà quel vecchio porco
dalla nostra primadonna ingenua?».
E lei, sospendendo la scena,
viene in avanti e a luci semispente
canta l’inno della sua autoassoluzione:
«”Vissi d’arte, vissi d’amore,
non feci mai male ad anima viva”.
Cantavo nel palazzo di Scarpia
ed ero la diva del suo regime di polizia,
ma portavo i fiori alla Madonna
e non capivo cosa succedeva.
E neanche adesso capisco veramente
cosa sta succedendo, a me, a noi,
perché debbo trovarmi così».
Sublime inno a generazioni di artisti
e intellettuali dell’incipiente Novecento
che si sarebbero chiesti perché loro,
che vivevano d’arte e d’amore,
si ritrovavano nell’Europa della guerra,
delle persecuzioni e delle stragi.
Quando finalmente lei capisce e cede,
Puccini, toscanaccio, non le fa dire neppure una parola,
ma la musica è un La e un Do, «La Do»;
sublime sintesi narrativa.
E poi fanciulle del West, battellieri della Senna,
principesse isteriche e serve apolidi.
E quando [nella “Turandot”] Liù si uccide per non tradire
Calaf ‒ che, senza guardare in faccia nessuno,
vince la lotteria della sua vita
e sfida la principessa per portare a casa
la stessa e il suo trono ‒ l’impressione è
che nella tomba cali la stessa opera lirica.
Dove vai ben so
«Dove vai ben so»
‒ dice il vecchio cieco che accompagna
fuori scena il corpo esanime ‒
«ed io ti seguirò per posare a te vicino
nella notte che non ha mattino!».
Toscanini finisce qui; è il 1924
e anche l’Italia sembra entrare
nella notte che non ha mattino,
ma anche Puccini visse d’arte e visse d’amore.
Alfano prende i pezzi che Puccini aveva rigirato
per anni senza essere capace di chiudere
con questa storia che lo ha consumato.
Di Alfano si dice che l’unica volta che
poteva copiare con licenza Puccini
non ce l’ha fatta, ma invero ha fatto di più:
ha dato una soluzione adatta all’epoca.
E di fronte alla tragedia dell’innocenza di Liù
l’opera finisce in «Fe-li-ci-bum-taaaaaaà».
Il melodramma diventa il musical, o meglio
diventa la rivista, il cartone animato
«fe-li-ci-bum-taaaaaaaaaà».
Dopo molti anni Luciano Berio scriverà
quel finale e risulterà un esercizio
di musica contemporanea, forse bella
ma lontana dal melodramma di popolo
suonabile dalle bande di paese.
Da una parte il musical popolare
dall’altra musica inaccessibile,
per élites, elegantemente lontane.
Nel terribile Novecento senza più illusioni né pietà
come Tosca, anche il Candide di Bernstein vive
d’arte e d’amore e crede il suo mondo perfetto
anche quando ritrova l’amata Cunegonde
esercitare in un bordello di Costantinopoli,
che canta che “per mestiere deve essere
brillante e gioiosa, Glitter and be gay”,
in un su e giù di ingorghi vocali che ripercorrono
tutta la storia delle nostre povere primedonne
sempre più sperse fra musical e tragedia.
Ma per questo il melodramma vive,
perché in fondo mette in scena noi stessi,
così che possiamo piangerne e riderne,
chiedendo a Verdi e ad ogni altro artista
di piangere, soffrire e gioire per noi e di noi.
Questo è il melodramma, gente!
[musiche scelte a cura del maestro Mirco Besutti]
[una parte dello spettacolo “Verdi e dintorni” è visibile sul canale YouTube della Filarmonica “Guglielmo Andreoli” di Mirandola (Modena)]